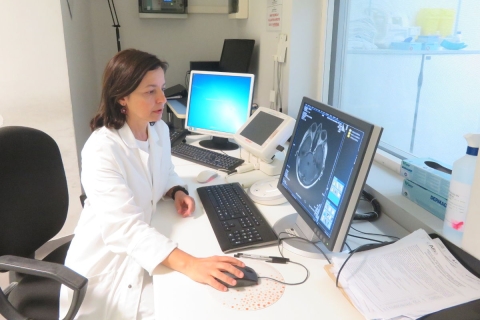Le persone con disabilità continuano ad essere discriminate sul lavoro, nella vita pubblica e nei media. Ma stiamo abbandonando, anche se con fatica, la cultura del pregiudizio. L'indagine pubblicata su SM Italia 2/2013
Per spiegare la diversità alla sua classe una maestra disegna alla lavagna tante persone e intorno a ognuna traccia un cerchio per indicare la categoria a cui appartiene. Tommaso, uno degli alunni, cancella il cerchio attorno alle persone disabili e ne disegna uno più grande che racchiude tutte le categorie.
A leggere la sceneggiatura di Trova l’errore, l’opera con cui Alessia Radaelli e Jahela Francesca Paglione hanno vinto la seconda edizione di Sapete come mi trattano? (il concorso promosso dalla Federazione per il Superamento dell’Handicap per raccontare la discriminazione in modo originale) si potrebbe pensare che, finalmente, la disabilità sia considerata «una parte del mondo e non un mondo a parte». Come recita la frase che compare vicino al cerchio disegnato da Tommaso. Ma è davvero così? Quanti farebbero quello che ha fatto Tommaso? La scuola, si sa, è un ambiente ‘privilegiato’ in cui i bambini imparano fin da piccoli a confrontarsi con la diversità.
E, anche se ci sono esempi negativi, come la mancanza degli insegnanti di sostegno che costringe gli studenti disabili a rimanere a casa come è accaduto di recente in Lombardia, il modello italiano di inclusione scolastica è senz’altro invidiato all’estero. Non è un caso che la rivista francese sulla disabilità ‘Déclic’ abbia inserito il nostro Paese tra quelli virtuosi in fatto di inclusione scolastica. «Se fin dall’asilo abituiamo i bambini alla presenza della diversità, quando saranno grandi avranno meno problemi a relazionarsi con chi è diverso – dice il giornalista Pietro Cheli – Credo stia nascendo una generazione migliore della nostra: inserire gli studenti diversamente abili nelle scuole insieme a tutti gli altri è un vantaggio».
Cheli ha scritto, insieme al genetista Guido Barbujani (autore di L’invenzione della razza. Capire la biodiversità umana, pubblicato da Bompiani), un libro che si intitola Sono razzista ma sto cercando di smettere (Laterza), sui luoghi comuni del razzismo. «La società sta cambiando e noi possiamo reagire in due modi, costruendo muri o affrontando la diversità», dice Cheli. La seconda è l’ipotesi preferibile, ovviamente, «pur presentando difficoltà, prima o poi porterà a un assestamento. E mi sembra che – continua – malgrado in Italia esista una cultura dominante basata su semplificazione e cliché, stiamo andando, anche se faticosamente, in questa seconda reazione». Nel volume, nato da un incontro tra i due al Festival della mente di Sarzana, gli autori fanno riferimento a un «software di base del razzismo». Che, sottolinea il giornalista, «è applicabile a tutte le diversità perché ciò che è diverso fa paura ed è più facile affidarsi a pregiudizi che non considerare chi è diverso da noi come una ricchezza e la complessità come un dato di fatto della società».Ma se nella scuola c’è una soglia di attenzione più alta, i problemi si riscontrano in altri ambiti. In primis il mondo del lavoro, seguito dai mass media.

Un po’ di dati
I numeri sulle discriminazioni confermano questa ‘preferenza’ per cliché e pregiudizi. Nella prima metà del 2012 sono state 900 le segnalazioni arrivate all’UNAR – l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – con un aumento del 90% rispetto al 2011. Le discriminazioni riguardanti il genere o l’orientamento sessuale hanno le percentuali maggiori, mentre quelle nei confronti delle persone disabili si attestano intorno al 5,6% (nel 2011 erano il 3%). «Le denunce sono in aumento – dice Marco Buemi dell’UNAR
– segno di una maggiore consapevolezza da parte delle vittime e dell’effetto delle campagne di sensibilizzazione». Se tra il 2010 e il 2011 sono stati i mass media l’ambito in cui si era registrato il maggior numero di episodi, i primi 10 mesi del 2012 hanno segnato un primato allarmante: quello del lavoro, contesto in cui si è verificato il 35,6% degli atti discriminatori (+15,4%). Complice anche la crisi economica.
«Oltre il 75% delle denunce riguarda la fase di entrata nel mercato del lavoro – afferma il referente dell’UNAR – In una situazione di crisi il mercato si restringe e le persone che si trovano in situazione di svantaggio fanno più fatica ad accedervi e sempre più spesso ne rimangono fuori». Due persone su 3, infatti, non hanno avuto accesso al mondo del lavoro perché disabili, per motivi etnici, per il loro orientamento sessuale o religioso. Il secondo ambito in cui è stato rilevato il maggior numero di discriminazioni è quello dei mass media, anche se le denunce si fermano al 15,1% del totale ovvero meno della metà rispetto al lavoro. In questo settore le discriminazioni riguardano ad esempio l’esclusione dai programmi di primaria importanza dal punto di vista informativo, culturale e politico per le persone che hanno difficoltà di tipo sensoriale. Lo scorso 29 gennaio l’Ente Nazionale Sordi (ENS) ha annunciato uno stato di agitazione con diffuse azioni di protesta contro ‘la quotidiana discriminazione operata dalla Rai’. L’accusa riguarda la mancanza di sottotitolazione e di traduzione nella Lingua dei segni per molti programmi e la pessima qualità di quei pochi che invece ne sono dotati. Eppure l’articolo 3 del contratto di servizio della tv pubblica parla espressamente di trasmissioni audiodescritte per garantire alle persone con difficoltà sensoriale un effettiva accesso alla programmazione.
«Sui mass media però le denunce più frequenti riguardano il linguaggio – continua Buemi – ovvero l’uso di termini impropri, stereotipati oppure offensivi». Sotto questo profilo, un grande strumento a disposizione dell’UNAR è la Carta di Roma, almeno per quanto riguarda le discriminazioni razziali, il codice deontologico su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti adottato nel 2008. «La carta ci permette di segnalare all’Ordine dei giornalisti competente a livello territoriale i casi di violazione delle sue previsioni», specifica Buemi. Non esiste un analogo codice deontologico sulla disabilità, anche se il segretariato sociale della Rai ha adottato fin dalla fine degli anni Novanta delle Linee guida sulle persone disabili, una sorta di Codice etico-linguistico per gli operatori della comunicazione radiotelevisiva.

Questioni di linguaggio
Le parole sono importanti e l’affermazione dei diritti passa anche attraverso l’evoluzione del linguaggio. E anche se l’uso di termini «politically correct» a volte, rischia di sfociare nella retorica «è comunque la spia di una diversa sensibilità», secondo Pietro Cheli. Che dice di preferire «diversamente abile» perché «le diverse abilità sono una ricchezza» mentre «handicappato è un termine brutto che suona male e che in passato era usato in senso dispregiativo». Insomma, «a costo di far ridere, preferisco usare espressioni meno insultanti e meno legate a cliché», afferma. Ma per diffondere una maggiore sensibilità sulla diversità i media tradizionali, radio, tv e stampa, non sono
sufficienti. «Sotto questo profilo, fa molto di più un film o un’opera che entra nella vita quotidiana dei disabili», dice Cheli. Qualche esempio? A parte ‘Rain Man’ di Barry Levinson in cui Dustin Hoffman interpreta una persona autistica, c’è ‘Più leggero non basta’ di Elisabetta Lodoli (1998) con Giovanna Mezzogiorno e Stefano Accorsi in cui la Mezzogiorno interpreta una donna disabile. In una scena la protagonista, in carrozzina, passa per una strada
in cui c’è una macchina parcheggiata di traverso. «È molto più efficace quell’immagine di qualsiasi comunicato stampa sulla presenza di barriere architettoniche», dice Cheli secondo cui «fare informazione sulla disabilità deve avere un’efficacia narrativa, deve raccontare una storia, magari di chi ce l’ha fatta».
Buone pratiche
Sono circa 5.000 le persone che si sono iscritte al sito del progetto Diversitalavoro promosso dall’UNAR insieme a Fondazione Sodalitas, People e Fondazione Adecco per le pari opportunità per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di laureati e diplomati con disabilità, iscritti alle categorie protette o di origine straniera. Ne sono stati selezionati circa 700, di cui il 69% con disabilità, il 29,5% di origine straniera e l’1,5% transgender. Di questi 700, 35 persone (il 5%) ha trovato lavoro con un contratto di stage (32%), a tempo determinato (21%) e indeterminato
(24%).
L’idea di Diversitalavoro nasce dalla volontà di dare una possibilità a persone che «pur avendo competenze spendibili di alto profilo, erano culturalmente rassegnate al fatto di poter ambire solo a certe posizioni lavorative a causa di una situazione di svantaggio», dice Paolo Beretta, coordinatore del progetto. L’esempio di Diversitalavoro dimostra che è possibile l’incontro tra domanda e offerta anche nel caso di categorie svantaggiate. Da cosa dipende la difficoltà di entrare nel mercato del lavoro? Dalla mancanza di attenzione da parte dei recruiter e dalla scarsa competenza sulla diversità da parte delle aziende. «Spesso le aziende si privano di un collaboratore valido ma con una malattia invalidante come può essere la SM perché non sanno quantificare le ore di lavoro che può garantire, perché si stanca prima degli altri o ha bisogno di cicli di cura – afferma Beretta – Per questo oltre ai Career Day, lavoriamo anche sul piano della formazione all’interno delle aziende, ad esempio, con i percorsi al buio per far capire ai manager come vive una persona cieca. L’obiettivo è non trovarsi vittima dei pregiudizi ed essere consapevoli di chi si ha di fronte». Ai Career Day hanno partecipato una cinquantina di aziende, tra cui Apple, Accenture, Decathlon, Philip Morris, Alitalia, Bnl portando opportunità concrete di lavoro. «Hanno partecipato non per rispettare la Legge 68 – conclude Beretta – ma perché consapevoli che inserire quesqueste persone è una ricchezza e porta contributi rilevanti».
Laura Pasotti